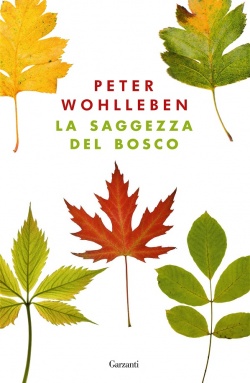Peter Wohlleben
« Un parco nazionale è la categoria di tutela più severa tra le riserve di grandi dimensioni. La natura deve dominare incontrastata, mentre l’uomo si ritira in buon ordine e assume il ruolo di semplice osservatore. Alla base c’è il concetto di Prozessschutz, vale a dire la preservazione dei processi naturali. Al contrario di una normale area protetta, non si mira a proteggere una determinata forma di paesaggio, né a mantenere e curare determinate specie, bensì l’intero complesso dei processi naturali. In pratica ciò si traduce nella rinuncia a qualsiasi forma di intervento e, aspetto ancora più difficile da tollerare per chi si occupa di tutela per professione, si rispetta l’esito aperto dell’evoluzione. »
La saggezza del bosco
2018
Gli alberi a crescita spontanea
Per rispondere alla domanda «che cos’è una foresta vergine?», si possono dare diverse definizioni. Per certi esperti, basta che la foresta abbia una certa quantità di legno in decomposizione, non sia stata sfruttata da lungo tempo e sia costituita da alberi antichi di varie specie a crescita spontanea. Una foresta vergine, quindi, può benissimo essere un ecosistema fortemente alterato da interventi antropici che però sta tornando al suo stato originario. Se questi sono i criteri, possiamo dire che di foreste vergini, in Europa centrale, ne abbiamo ancora. La mia definizione, tuttavia, è più restrittiva: foresta vergine per me è un vero e proprio bosco primario rimasto intatto.
Come migrano gli alberi
Alla fuga degli alberi sotto l’avanzata del ghiaccio c’era un ostacolo sostanziale: le Alpi. Qui la glaciazione aveva già inibito il riprodursi degli alberi e quindi successive «migrazioni» verso sud. Quelle specie arboree che non trovavano una nicchia climatica adatta o che crescevano già a sud delle Alpi, nella Germania meridionale, furono travolte dai ghiacci e si estinsero in tutta Europa. Vittime predestinate furono per esempio la douglasia e alcuni tipi di quercia.
Al termine dell’era glaciale, con l’aumento delle temperature, osarono uscire dai loro nascondigli nell’Europa meridionale per tornare verso nord. I primi ad attecchire furono i «velocisti», come betulle e pini che, con l’ulteriore aumento delle temperature, vennero sostituiti dalle querce. Circa 5000 anni fa ci fu una svolta, perché il clima si fece di nuovo un po’ più fresco e umido. A questo punto, prima del massiccio intervento dell’uomo, il faggio intraprese una vera e propria marcia trionfale in Europa, e se non l’avessimo fermata ora occuperebbe perfino la Scandinavia meridionale. Quindi, in fin dei conti, non può essere così lenta e il segreto della sua diffusione è lo stesso della sua sopravvivenza durante l’era glaciale: sono stati i suoi alleati animali, come topi, scoiattoli o ghiandaie, che vanno matti per i suoi semi ricchi di grassi. Raccolgono i frutti e li accumulano nei vari depositi per l’inverno, in modo che la scorta duri fino alla primavera successiva.
Perché i faggi?
La quercia è in grado di tollerare bene freddo, caldo e anche siccità estiva, un clima continentale.
E il faggio? Ebbene, gli piace proprio il nostro clima mitteleuropeo, caratterizzato da inverni piuttosto miti, estati fresche e sufficiente umidità: un clima temperato umido influenzato dall’Oceano Atlantico che lo fa crescere in piena forma. Ma non è l’unico segreto della sua marcia trionfale in Europa. Ci sono altre due qualità che lo hanno aiutato ad aprirsi una breccia. Da una parte la capacità di crescere anche all’ombra di altri alberi. Capita che si insedi sotto una quercia, cresce lentamente e alla fine penetra attraverso la sua corona. La quercia, specie eliofila che necessita di molta luce per sopravvivere, viene sopraffatta dal faggio, che la supera in altezza e la oscura, e alla fine muore. E come se non bastasse, i faggi si danno parecchio da fare anche con le radici. Con la cacciata di numerosi stoloni si insinuano anche nella più piccola fessura, penetrano l’apparato radicale della quercia sottraendole sostanze nutritive e acqua.
Il ciclo naturale del faggio
La faggeta è detta anche «madre del bosco». Gli esperti usano questo appellativo in riferimento all’effetto benefico che il faggio esercita in termini di microclima e incremento della fertilità del suolo attraverso la produzione di humus. Io l’estenderei volentieri al carattere e al modo di vivere di questi alberi.
Ogni albero vuole diventare grande, e anche il più in fretta possibile. È nei suoi geni e se avesse piena libertà di fare come vuole, metterebbe subito in pratica le sue intenzioni. Il risultato sarebbe un fusto fatto di legno a cellule grosse. Queste contengono però molta aria e perciò sono più suscettibili alla rottura e diventano altresì un ricettacolo ideale per funghi xilofagi, che si sviluppano in ambiente aerobico. {{yellow|Un albero che cresce in fretta diventa sì grande ma non particolarmente vecchio, a causa della qualità scadente del suo legno.*} Quando vedete un esemplare sradicato da una tempesta, si tratta probabilmente di un albero cresciuto troppo in fretta. Una crescita rapida richiede luce e a catturarla sono gli alberi vecchi. Con la loro chioma folta, riducono l’irradiazione solare del sottobosco al punto che, ai loro piedi, solo il 3% di luce raggiunge il suolo. Le «farfalline» vengono frenate da subito nel loro sviluppo e costrette a formare legno lentamente. Le celle dei minuscoli fusti restano piccole e stagne, quindi elastiche e inadatte all’insediamento di funghi. Di conseguenza, una volta adulte possono raggiungere età di tutto rispetto perché, in caso di tempesta, oscillano senza spezzarsi. Le lesioni del tronco comportano più raramente putredine del legno e quindi è più difficile che si crei una condizione di instabilità letale.
Questa educazione impartita dai genitori è tuttavia una faccenda noiosa. Le giovani piante hanno una crescita annuale che non supera il centimetro, una vera pretesa. I figli dei faggi rischiano di morire perché in quella penombra con le loro foglie sparute non producono quasi zucchero. La salvezza giunge dal sottosuolo: le radici tenere degli alberi un po’ più grandi formano un viluppo con quelle delle generazioni più giovani fornendo loro le sostanze nutritive necessarie a restare in vita. È questo che permette alle pianticelle di resistere a lungo. Il tempo non conta e il tempo di attesa può tranquillamente protrarsi per 200 anni e oltre. In alto, il figlio di un faggio può arrivare solo quando la pianta madre se ne va all’altro mondo. Con la sua morte la luce filtra indisturbata fino ai piani più bassi e, per la pianticella, è il via alla rapida conquista del suo spazio aereo. Tuttavia solo per quelli che fino a quel momento sono cresciuti bene. Il tronco dovrebbe essere dritto come un fuso e non perché è più bello o perché è più facile ricavarne delle assi ma perché un tronco diritto è più stabile. In questo caso, le fibre legnose hanno un andamento perfettamente longitudinale e quindi in caso di tempesta l’albero è in grado di reggere uniformemente le sollecitazioni del vento e distribuire le forze lungo tutto il suo corpo. Un albero curvo e storto, invece, deve già lottare duramente in condizioni normali per non spezzarsi. La leva esercitata su un esemplare alto 40 metri è enorme. La gigantesca corona di tonnellate rischia di sradicarlo e quindi l’albero provvede ad accumulare in fretta legno come rinforzo nei punti di maggiore curvatura. Quando tutto è tranquillo può bastare: in caso di tempesta, prima o poi, il carico diventerà insostenibile. Uno schianto repentino e l’albero è a terra.
Per evitare che ciò accada, i faggi crescono in gruppi, con la cacciata apicale (porzione di fusto in cima prodotta nell’ultima stagione vegetativa) che cresce centimetro per centimetro, anno dopo anno. Se uno dei virgulti si mette in testa di crescere storto e ricurvo, arriva subito la punizione. Allungarsi lateralmente non significa altro che arrivare meno in alto. Di conseguenza, i rami normali, ovvero quelli dritti, lo superano lasciandolo nell’oscurità. Il 3% di luce solare che filtra attraverso il tetto di foglie degli alberi più grandi non raggiunge più il «deviante», che alcuni anni più tardi morirà per tornare a essere humus.
Quanto sia lenta questa fase giovanile l’ho scoperto pochi anni fa per caso in una faggeta antica. Sotto un faggio maestoso c’era il suo discendente, un faggio di circa ottant’anni. Era alto solo un metro e mezzo, il suo piccolo fusto spesso appena quanto un dito. Affinché diventi adulto, passeranno di sicuro altri trecento anni. Forse vi chiederete come ho fatto a sapere l’età del «giovane» faggio. Dopotutto non intendevo abbatterlo, tanto più che non sarebbe stato assolutamente possibile individuare e contare gli anelli di crescita su un legno ancora caratterizzato da una crescita così lenta. Sono i rami che rivelano l’età. Alla fine dell’estate sui nuovi ramoscelli si formano lievi rugosità, come fossero nodi scanalati. Il loro numero fornisce una stima attendibile degli anni. In un faggio giovane, i rami sono pieni di questi nodi che testimoniano la dura scuola di vita che stanno facendo.
L’affollamento all’«asilo» ha un ulteriore effetto educativo, ossia evitare che si formino rami laterali troppo grossi. Gli alberi devono puntare con tenacia in alto, non sprecare tempo a ramificarsi lateralmente. Tuttavia questo fenomeno non si può evitare del tutto perché le foglie devono pur crescere da qualche parte. Se la formazione fogliare avvenisse solo sulla cacciata apicale, in cima quindi, i discendenti non riceverebbero praticamente luce. Inoltre, più larghe sono le minuscole corone e più energia solare possono accumulare. Nel corso della loro vita futura, i faggi si devono sbarazzare di queste ramificazioni perché quando si sviluppano ulteriormente i getti in cima, sotto diventa troppo buio per le foglie. Di conseguenza i rami si seccano e il tessuto morto costituisce una via di accesso per i funghi che cercano di penetrare nel legno e quindi dentro all’albero. Adesso comincia la corsa col tempo. Per fermare l’avanzata degli intrusi, il faggio isola il ramo morto. Col tempo questo si stacca e il moncone viene ricoperto da tessuto vivo. Una riparazione di questo tipo ha una durata di parecchi anni che varia a seconda del diametro. Da un punto di vista statistico, l’albero riesce a riformare una barriera ermetica prima che il fungo sia penetrato in profondità se lo spessore del ramo morto è inferiore ai cinque centimetri. La cicatrizzazione delle lesioni più estese richiede più tempo, l’albero non riesce a riparare i tessuti abbastanza rapidamente e così l’armata devastatrice usa questa breccia per invadere il midollo. Un esemplare infestato dai parassiti può anche durare qualche decennio ma non diventerà mai vecchio come i suoi compagni.
Se i discendenti sono molto vicini tra loro e crescono insieme per anni protendendosi verso il sole, si fanno ombra a vicenda sui fianchi. E quindi i rami laterali muoiono prima di diventare troppo massicci. Questo è anche il motivo per il quale gli alberi possenti delle foreste vergini hanno fusti così belli lisci. Solo quando sono arrivati al piano superiore, possono sviluppare una grande corona ramificata senza pericolo.
Ma torniamo alla gioventù. I devianti sono scartati e fra le migliaia di pianticelle, solo una manciata di adolescenti cresce brava e ben educata sotto la pianta madre. E la cosa continua quando questa muore. Adesso la situazione si fa, per un’ultima volta, davvero pericolosa. Alla morte del vecchio faggio, infatti, nel giro di pochi mesi i grossi rami si spezzano e cadono, a volte crolla addirittura l’intero albero. E dove si abbatte, fa danno. Con la corona a pezzi, un successore al trono può scordarsi le sue ambizioni e deve cedere il passo a uno dei concorrenti rimasti.
Chi supera indenne questa ultima prova di resistenza, può raggiungere i piani alti e diventare adulto. Per ogni embrione che cade al suolo in autunno dentro una faggiola, la probabilità di farcela è in media di 1:1,7 milioni. Animali affamati, l’educazione severa o gli incidenti decimano a tal punto le nuove generazione che in quattro secoli solo un albero completa il suo ciclo di vita. Ma ciò basta alla conservazione della specie.
Ora il faggio ha alle spalle la fase più difficile e può dedicarsi alla sua occupazione principale: crescere. L’altezza massima è di 50 metri, ma la corona è in continua espansione laterale e anche lo spessore del tronco è in costante aumento. Ma un faggio non cresce da solo: tramite le radici è in contatto con i suoi simili. La comunità funziona come vero e proprio social network, su cui ci si scambiano notizie (per esempio che è in arrivo un attacco di parassiti) o si condividono mezzi di sostentamento come la soluzione zuccherina. Questa forma di «foraggiamento», certo, non è necessaria fra alberi di grandi dimensioni, ma se uno si ammala l’aiuto del vicino può salvargli la vita. Se uno si indebolisce, gli altri gli pompano nelle radici nutrimento quasi allo stato liquido.
Io vedo cosa tu non vedi
I faggi non hanno occhi, almeno non come i nostri. Eppure «vedono» la luce e per la precisione con centomila organi simultaneamente: le foglie. Dato che i raggi del sole sono praticamente il loro «cibo preferito», la sensazione che probabilmente provano è quella che avremmo noi davanti a un ricco banchetto. Ora si potrebbe eccepire che la vista e la fotosintesi sono due cose completamente diverse. Va bene, osserviamo un altro fenomeno. Con i primi caldi primaverili, fiori ed erba ricominciano a vivere. Ovunque dal terreno spuntano verdi germogli e anche i faggi potrebbero ripartire daccapo. Se non ci fossero gelate tardive. Se ad aprile il termometro scende di nuovo a meno cinque, foglie e butti nuovi morirebbero di freddo. Per evitarlo, gli alberi aspettano. Ma come fanno a sapere che mese è? Avvertono, cioè «vedono» la lunghezza delle giornate. E, combinandola con l’aumento delle temperature, attendono il momento propizio per la germogliazione. E questo momento è l’inizio di maggio. Quindi è chiaro che gli alberi non «vedono» solo con le foglie, dato che queste sono ancora alla forma embrionale. La corteccia sottile, in particolare quella che avvolge le gemme, lascia evidentemente penetrare luce a sufficienza in modo da veicolare queste informazioni.
Un momento. Per ora abbiamo parlato della vista, ma, senza che ce ne accorgessimo, è emerso un altro aspetto: la capacità di percepire sensazioni. Caldo o freddo, il faggio sente inequivocabilmente qualcosa. E infatti lo dimostra di nuovo ogni anno, ed è capace anche di molto altro. Avverte perfino dolore. Non esiste una dimostrazione diretta ma c’è tutta una serie di elementi indiretti, sufficientemente chiari e anche molto emozionanti. Perché il faggio condivide ciò che prova con i suoi simili.
Già diverse decine di anni fa, gli scienziati hanno osservato un comportamento curioso nelle gazzelle della savana africana. Le gazzelle rosicchiavano il verde fogliame delle acacie a ombrello, ma dopo pochi minuti passavano a un altro esemplare, a una distanza fra i cinquanta e i cento metri almeno. Uno studio ha dimostrato che le acacie nelle dirette vicinanze di quella «attaccata» dalle gazzelle avevano veicolato sostanze velenose come difesa, cosa che evidentemente gli animali sapevano. Ma le altre acacie come facevano a sapere dell’attacco imminente? Era stato il vento a trasportare questo segnale di allarme chimico, un messaggio olfattivo della pianta le cui foglie erano già state mangiate.
Nel corso di questi anni si è capito che molte specie arboree comunicano intensamente fra loro. Ma ciò vale probabilmente per tutte le piante. Vero, si tratta «solo» di messaggi olfattivi, ma è un mezzo di comunicazione non meno valido della nostra lingua parlata, che si trasmette mediante onde sonore.
L'arboricoltura
I danni del suolo
Con l’aratura il terreno veniva al massimo un po’ scalfito. Eppure, nel punto in cui l’aratro raschiava il sottosuolo, si mescolavano fango e argilla e, proprio come avviene nella produzione della terracotta, si formava una superficie stagna e impermeabile all’acqua.
Ergo, sia che l’aratro fosse trainato da mucche o da pecore, le conseguenze sono visibili ancora oggi. Perché il terreno danneggiato non si rigenera più nel modo in cui lo intendiamo noi. Certo, i venti centimetri più superficiali sono sottoposti a un processo di dissodamento naturale sotto l’azione del gelo e degli zoccoli degli animali, ma sotto è finita per sempre. Lo strato di sbarramento funziona come una vasca che, in caso di piogge intense, non scola acqua. Il terreno si riempie di acqua e in poco tempo diventa come un acquitrino. Sotto, qualsiasi forma di vita si secca, sopra annega. A questo punto verrebbe logico pensare che l’area diventi una palude e vi si insedino piante tipiche di questo habitat. Ma purtroppo neanche questo funziona, perché, data la sua scarsa profondità, la vasca si prosciuga dopo pochi giorni sotto l’azione del sole.
Quasi del tutto disboscato, il nostro paesaggio è stato sottoposto in gran parte a un processo di riforestazione, ma questi alberi hanno vita davvero difficile. Il terreno rovinato è veleno per le loro radici e non appena raggiungono lo strato di sbarramento le loro tenere propaggini muoiono a causa della mancanza di ossigeno. E ciò vale per la maggioranza delle specie arboree.
Questo è il motivo del mito degli alberi con le radici piatte, fra i quali si annovera senz’altro il faggio. Il suo apparato radicale si sviluppa solo attraverso i venti centimetri più superficiali, che godono ancora di una sufficiente aerazione. Non costituisce però un saldo ancoraggio in caso di tempeste violente, quando la forza di trazione sul tronco è di cento tonnellate. In questi casi anche l’albero più robusto si rovescia.
Esordi difficili
Il taglio delle radici è un intervento pesante, una menomazione a vita. Da questo trattamento radicale, paragonabile all’amputazione di una gamba umana, non si riprendono più. Le querce, per esempio, che normalmente si ancorano in profondità, da quel momento buttano radici solo in superficie. Non riescono più ad aggrapparsi saldamente al terreno e soprattutto quelle più alte restano facilmente vittima delle tempeste. Inoltre soffrono della mancanza di acqua perché essa scorre negli strati più profondi e quindi per loro è irraggiungibile. Se poi ci si aggiunge un terreno precedentemente deteriorato è come condannarle a una malattia cronica programmata.
Ecco dunque i nostri alberelli come pedine su una scacchiera. In natura avrebbero dovuto sottostare alla dura educazione dei genitori. Sarebbero trascorsi cento anni e più di privazioni durante i quali i loro teneri fusti si sarebbero trasformati in tronchi duri e nodosi imparando a fare un uso parsimonioso dell’acqua e crescendo piano piano. Nella piantagione, invece, regna l’abbondanza. In pieno sole, si hanno ampie opportunità di attuare la fotosintesi e produrre un concentrato di energie sotto forma di zucchero. Anche le sostanze nutritive del terreno sono presenti in grande quantità, dato che lo spesso strato di humus dell’antico bosco su cui è poi sorta la piantagione viene decomposto a ritmo vertiginoso sotto la luce diretta del sole e rilascia più sostanze minerali di quanto le pianticelle non abbiano bisogno.
Taiga artificiale
In Siberia e nella Scandinavia del Nord, il periodo vegetativo è breve. La crescita di fusto e foglie dura meno di uno o due mesi e in queste condizioni le latifoglie hanno vita difficile. In primavera devono generare le foglie per poter poi produrre zucchero e legno. La sontuosa corona deve essere deposta in tempo prima dell’arrivo dell’inverno, per riprendere daccapo il ciclo l’anno successivo. Per poche settimane, un simile dispendio di energie non vale la pena. Inoltre, in queste condizioni estreme, un albero deve essere in grado di reagire in fretta. Se viene caldo, deve innescarsi subito la fotosintesi. Chi si trastulla e deve per prima cosa generare foglie, ha già perso in partenza. Ecco perché abeti rossi e pini non si spogliano del loro verde splendore. Per difendersi dalla stagione fredda, essi immagazzinano negli aghi una sostanza antigelo (quella che provoca scintille se avvicinate gli aghi alla fiamma di una candela) e consente alla pianta di sopravvivere alla neve e al ghiaccio. Con i primi timidi raggi di sole, possono iniziare subito a crescere e continuare poi fino all’ultimo giorno tiepido del primo autunno. Le condizioni ambientali sono così dure che anche dopo cento anni l’altezza totale non supera i cinque metri.
Trasferiti nell’Europa centrale, questi asceti restano spiazzati. Hanno tempo di crescere da aprile a settembre, quindi per sei mesi pieni. Inoltre il sole qui è molto più alto, motivo per cui gli aghi si prendono una porzione extra di luce. Come i muscoli di un atleta dopato, rami e fusto si gonfiano. La crescita annuale può toccare anche il mezzo metro, dieci volte tanto quanto avviene nella loro patria natale. Se stanno bene? Non credo. Perché in Europa centrale abeti rossi e pini soffrono una sete terribile. Nell’estremo Nord piove di più e inoltre è molto più fresco, quindi l’evaporazione dell’acqua è minore e il suolo resta umido più a lungo. Periodi di siccità, come ne capitano regolarmente in Europa centrale in estate, questi alberi sempreverdi non ne conoscono, perciò non sono abituati alle nostre giornate molto calde e secche. Ciò ha gravi ripercussioni. Nel tessuto dei nuovi arrivati s’infiltrano diversi parassiti xilofagi, gli scolitidi. «Tipografo» (bostrico tipografo) e «calcografo» (bostrico calcografo) sono nomi simpatici, ma fanno tremare molti proprietari di boschi. Derivano dalla forma cesellata dei cunicoli che questi coleotteri scavano sotto la corteccia. In realtà il tipografo è un parassita che attacca solo piante deperienti, cioè malate o indebolite. Tutte le specie, anche il nostro faggio, conoscono questi seccatori. Se l’albero è sano, si difende dagli attacchi mediante l’accumulo di sostanze tossiche nella corteccia o, nel caso delle conifere, mediante la secrezione di resina in cui il parassita annega letteralmente. Ciò funziona solo se il fusto è sano e robusto. Ma abeti rossi e pini soffrono costantemente la sete e quindi si disidratano. Se un tipografo si scava una galleria nella corteccia nei caldi mesi d’estate, di resina spesso non ne arriva neanche una goccia, e di ciò il coleottero si accorge subito. Emette un richiamo olfattivo che segnala ai simili: «Il buffet è pronto!». Al che tutti i bostrichi della zona si mettono in volo e si siedono alla tavola imbandita. In men che non si dica la corteccia si riempie di fori sotto ciascuno dei quali c’è la cavità in cui avverrà l’accoppiamento. Ed è qui che, in minuscole nicchie, le femmine depongono le uova da cui escono le larve che a loro volta scavano cunicoli attraverso la corteccia. Amano in particolare il cambio ad alto contenuto di zucchero, lo strato in cui si crea il nuovo legno e che permette all’albero di crescere: in pratica, l’albero viene scorticato vivo. Raggiunto un certo livello d’infestazione, non ce la fa più. La corteccia si sfalda e gli aghi prendono una colorazione rossiccia, segno della fine. Migliaia di giovani coleotteri si mettono alla ricerca di altre vittime e attaccano altri alberi nelle vicinanze. Certe volte basta che venga attaccato anche un solo esemplare e, nel giro di un’estate l’infestazione si diffonde a macchia d’olio arrivando a colpire fino a cento alberi, perché ogni sei settimane si schiudono le uova con nuove larve. Ergo, le piantagioni di conifere oggetto di così tanta cura si trasformano rapidamente in paesaggi desolati punteggiati da scheletri.
Se dopo sessant’anni i pecci hanno raggiunto un’altezza di venticinque metri e più (i pini riescono a diventare anche un po’ più alti), entrano in gioco le regole della fisica, perché il fusto finisce per assomigliare a una lunga leva sulla cui estremità superiore poggia la corona, ed è sottoposta a violente sollecitazioni. Ogni autunno, nell’Europa centrale si scontrano e mescolano masse d’aria calda provenienti da sud e correnti fredde da nord. Il risultato è lo scatenarsi di tempeste.
I nostri alberi nativi hanno sviluppato una difesa. Si sbarazzano delle foglie riducendo così la superficie esposta all’attacco del vento e resistono a qualsiasi uragano, senza perdere l’equilibrio. Secondo me, è questo il motivo principale della caduta delle foglie. Le conifere invece no, eccezion fatta per il larice, che però dal punto di vista della silvicoltura ricopre un ruolo del tutto marginale. La caduta delle foglie, nelle regioni da cui provengono, non era neanche necessaria, perché, a quelle latitudini, venticinque metri di fusto sono un’altezza utopica che nessun albero di fatto raggiunge mai. In Europa centrale invece, durante le bufere autunnali, stanno come militi indifesi in una postazione sperduta. Con un vento di cento chilometri orari cadono o si spezzano non solo singoli esemplari, ma gruppi di alberi quando non addirittura interi boschi. È il modo con cui Madre Natura ci mostra come questi alberi siano del tutto fuori posto, qui.
Nelle foreste di latifoglie dell’Europa centrale, la situazione è però molto diversa. Qui non sono scoppiati periodicamente incendi e dunque i boschi non sono stati rasi al suolo. Fate la prova per conto vostro: prendete un accendino e cercate di appiccare il fuoco a un ramo verde di faggio. Non ci riuscirete, mentre ben diverso è per le conifere: gli oli eterici di cui sono impregnate e che le aiutano a sopravvivere al gelo costituiscono condizioni favorevoli all’attecchimento del fuoco.
Il taglio raso implica la sparizione della pedofauna, che cede il posto a quelle specie animali che hanno bisogno di spazi aperti. L’aumento della biodiversità avviene quindi solo nel nostro campo visivo, secondo il motto «oribatidi contro farfalle», e per i responsabili questa è un’argomentazione del tutto sufficiente.
Mettere sotto tutela
Sforzi discutibili
È paradossale. Per migliaia di anni i nostri antenati si sono forzati di domare la natura per renderla del tutto innocua e per trarne profitto, e adesso ne paghiamo le conseguenze. Non ci sono più predatori che creino problemi agli allevatori, i boschi selvatici sono stati abbattuti e sostituiti da campi, pascoli e riserve di legna. Era questa l’immagine del Paradiso che avevano i nostri antenati. Ma a quanto pare la cancellazione del lato selvatico della natura ha implicato anche la sparizione dell’anima del nostro spazio vitale che ora ci manca dolorosamente. È giunto il momento di cambiare direzione agli ingranaggi della storia. Ma non troppo, perché ci sentiamo molto a nostro agio nella steppa culturale. Espressione di questa contraddizione sono le aree protette create negli ultimi cento anni. La natura incontaminata, infatti, non è presente nelle riserve ufficiali. Ed è giusto così, dato che ogni area protetta è sottoposta a un piano di gestione che indica quale forma debba assumere.
Le valli torrentizie in particolare soffrono di questa pianificazione della domenica. Un corso d’acqua che scorre gorgogliando romanticamente tra prati fioriti è molto apprezzato dagli escursionisti. Se poi sui fiori svolazzano leggiadre farfalle, l’idillio è perfetto. Questo però vale solo per i turisti. Gli organismi acquatici al contrario soffrono invisibili sotto la superficie.
In natura i corsi d’acqua sono fiancheggiati da boschi. In questo caso eccezionalmente non sono favoriti i faggi, bensì ontani, frassini, querce o pioppi. Questi alberi inoltre regolano la temperatura dell’acqua. A marzo, prima che spuntino le foglie, il sole riesce ancora a scaldare il torrente. Le larve delle salamandre, i granchi e i pesci d’acqua dolce ne traggono vantaggio. Verso maggio gli ontani e i pioppi mettono le foglie e schermano il sole. In questo modo il calore è mitigato e l’acqua resta piacevolmente fresca. In autunno, con la caduta delle foglie, gli alberi permettono di nuovo ai raggi solari di raggiungere l’acqua in modo che gli abitanti del torrente possano essere ancora attivi. Un perfetto gioco di squadra, che tuttavia non piace all’uomo. Per questo le valli torrentizie vengono tenute sgombre, anche nelle aree protette, perché è molto più bello andare a camminare sotto i raggi del sole…
Lungo i corsi d’acqua spesso viene mantenuta solo una fila di alberi, per dare almeno visivamente un’idea di natura. Come motivazione è spesso addotta la tutela di specie volatili che a loro volta dipendono dai prati. In realtà si tratta spesso di specie emerofile, che hanno seguito l’uomo nel corso degli ultimi millenni. E adesso sono utilizzate come alibi per una forma di tutela ambientale che difende tutto, tranne la natura incontaminata.
A voler essere precisi, ciò che si pratica in queste aree è una forma di giardinaggio paesaggistico, l’allestimento di parchi armoniosi.
La controversia dei parchi nazionali
Un parco nazionale è la categoria di tutela più severa tra le riserve di grandi dimensioni. La natura deve dominare incontrastata, mentre l’uomo si ritira in buon ordine e assume il ruolo di semplice osservatore. Alla base c’è il concetto di Prozessschutz, vale a dire la preservazione dei processi naturali. Al contrario di una normale area protetta, non si mira a proteggere una determinata forma di paesaggio, né a mantenere e curare determinate specie, bensì l’intero complesso dei processi naturali.
Nessuno può sapere se il territorio si trasformerà veramente in una foresta vergine, né quali specie vegetali prenderanno piede. È questo l’aspetto più emozionante dei parchi nazionali che li rende estremamente interessanti per gli scienziati. Questo concetto è applicato soprattutto in Brasile, Sudafrica o Canada. Grandi porzioni delle foreste e savane locali sono lasciate in pace, flora e fauna non sono disturbati dall’uomo, a parte gli occasionali safari. Dovrebbe essere una cosa del tutto naturale, peccato che in Germania non lo sia affatto.
Qui i parchi nazionali sono tenuti rigorosamente al guinzaglio. Ma, per fare in modo che tutto sia corretto da un punto di vista formale, si usa la definizione Zielnationalpark (parco nazionale di finalità). E qui cominciano i cavilli. Finalità significa che non si è ancora arrivati a destinazione. C’è dunque un percorso da seguire per raggiungere la meta in un futuro lontano. La tabella di marcia prevede un periodo di trent’anni in cui è ancora possibile l’intervento umano. Ma questi interventi sono realizzati purtroppo non da biologi o altri esperti di tutela ambientale, bensì da forestali e affini, ovvero proprio da quel gruppo di persone dal quale il bosco dovrà essere difeso in futuro. Sarebbe come affidare la gestione dei ricoveri per animali a un macellaio, garantendogli di poter continuare a esercitare la propria attività.
Sotto tutte le cime degli alberi è quiete
A volte le cose vanno diversamente: un’estate mi capitò di trovare regolarmente cubetti di ghiaccio nel bosco. Mi domandavo da dove potessero venire. Anche in inverno sarebbe stato difficile trovare una spiegazione, perché non si trovano pozzanghere che potrebbero ghiacciare. Un giorno arrivai alla soluzione del mistero. Si trattava di un signore anziano, che aveva sepolto la moglie nella foresta e che le portava ogni volta un ghiacciolo a forma di cuore. Li preparava a casa riempiendo d’acqua uno stampo che metteva nel congelatore. Il cuore si scioglieva nella calura estiva e penetrava lentamente nella terra sopra l’urna. Rimasi commosso.
Il futuro del bosco
La moria dei boschi
Spargendo il letame si liberano enormi quantità di ammoniaca che, oltre a puzzare in maniera micidiale, viene portata dal vento nei boschi, dove fa aumentare l’acidità del terreno e funge inoltre da concime, accelerando la crescita delle piante. In effetti negli ultimi vent’anni i nostri boschi hanno prodotto più legname di prima. Per quanto possa sembrare un dato positivo, in realtà si tratta di un processo debilitante per i soggetti già duramente provati. L’energia che serve per la crescita viene sottratta alle difese contro le malattie. Inoltre, le cellule del legno cresciute in fretta sono molto grandi e contengono molta aria, creando così condizioni favorevoli alla proliferazione di funghi dannosi che si annidano proprio in questi alberi. Nel giro di pochi decenni molti tronchi marciscono dall’interno diventando cavi. Gli effetti negativi della concimazione con letame perdurano a tutt’oggi, mentre l’inquinamento dell’aria in generale è diminuito, e quindi almeno l’acidità della pioggia è tornata a livelli accettabili.
La comprensione dei processi naturali deve essere molto limitata negli ambienti delle istituzioni forestali, altrimenti non si spiegherebbe come mai la moria dei boschi a tutt’oggi venga combattuta in maniera decisamente bizzarra. Come tutti abbiamo imparato durante le lezioni di chimica a scuola, la calce neutralizza gli acidi. E allora che cosa c’è di più semplice che spargere calce sui terreni boschivi per annullare l’effetto dell’acidità? E infatti da vent’anni migliaia di chilometri quadrati sono cosparsi di calce. Laddove i terreni sono impervi, questo viene fatto con l’ausilio di elicotteri dotati di appositi contenitori che volano sopra gli alberi e spargono la presunta medicina. All’inizio della mia attività anch’io ho usato questo metodo nella mia riserva. Peccato davvero, perché ora so di aver danneggiato il suolo.
I contadini erano soliti dire: «La calce arricchisce i padri e impoverisce i figli». Ciò significa che con questa sostanza si ottengono grandi raccolti nell’immediato, ma sacrificando la fertilità futura del suolo. La polvere bianca infatti accelera così tanto la vita nel terreno, che batteri e funghi consumano l’humus a grandissima velocità. In questo modo liberano una gran quantità di nutrienti che fanno prosperare le piante. Ma in realtà si tratta di un fuoco di paglia. Infatti, una volta consumato tutto l’humus, l’effetto diventa contrario. I nutrienti sono finiti e viene a mancare anche un’altra importante qualità dell’humus, ovvero la capacità di trattenere l’acqua. I terreni si seccano più velocemente e le piante stanno peggio di prima.
Il legno e il suolo, infatti, immagazzinano la CO2 che l’albero ha sottratto all’atmosfera durante il processo di crescita. Ma quando inizia la decomposizione dell’humus, i suoi elementi sono scomposti da microorganismi che rilasciano anidride carbonica. Quando l’humus sparisce del tutto per effetto della calce, si sprigionano nell’aria fino a 20.000 tonnellate di CO2 per chilometro quadrato: non c’è modo peggiore per utilizzare i fondi destinati alla difesa del clima.
Nel 2011 il ministero federale per l’Alimentazione, l’economia e la difesa del consumatore annunciò che i faggi in particolare erano gravemente compromessi. In effetti questa specie presentava in estate una quantità di foglie assai ridotta, in tutto il paese. La causa era una intensa fioritura e la conseguente abbondante fruttificazione. I rami erano già occupati e quindi non c’era più posto per le foglie. Diagnosticare un peggioramento delle condizioni di salute da questo particolare mi sembra alquanto avventato. Anche durante annate particolarmente asciutte, come il 2003 e il 2011, molti alberi perdono aghi e foglie per ridurre la superficie di evaporazione. Significa che sono malati? È come se vi mandassero dal medico tutte le volte che avete sete.
Il campanello d’allarme vero è quando ci sono rami morti nella parte superiore della chioma. In questo punto, infatti, si formano i germogli più giovani e particolarmente vitali. Se l’albero perde sostanza qui, significa che è malato. Con il passare del tempo diventa sempre più piccolo, perché i rami morti si spezzano al primo temporale. A un certo punto la modesta chioma rimasta non basta più a nutrire il tronco ancora possente, e l’albero muore.
I cambiamenti climatici
Fondamentalmente ottenere elettricità dal Sole, dal vento o dall’acqua ha senso. A conti fatti il bilancio ecologico di queste fonti energetiche è positivo; i gas serra si presentano solo durante la costruzione e la manutenzione degli impianti. Che cosa c’è allora di male a forzare questa trasformazione, in modo che a un certo punto tutti utilizzeremo solo energia «verde»? In realtà niente, a patto che la trasformazione sia condotta fino in fondo. Per avere un bilancio climatico positivo, bisognerebbe sostituire completamente petrolio, carbone e gas. Per ogni kilowatt prodotto da una pala eolica, bisognerebbe lasciare nei giacimenti un kilowatt di combustibile fossile, che non dovrebbe più essere estratto. Ma non è ciò che accade. La nostra energia pulita entra nel mercato energetico globale e significa soltanto che altri d’ora in poi utilizzeranno più petrolio, carbone e gas. Con ogni pannello solare aumentiamo la quantità di energia disponibile sul mercato. E dato che l’energia è utilizzata per trasformare la natura, significa che ogni kilowatt di energia pulita provoca nuovi danni ambientali.
Energia dal legno
Per diversi anni, circa quattrocento scienziati europei e d’Oltreoceano hanno studiato gli effetti delle varie forme di sfruttamento del terreno sul clima. Nel rapporto c’è anche un capitolo sul bosco. Quando l’ho letto, la mia illusione di neutralità climatica è andata in frantumi. Secondo questo studio, infatti, i boschi non sono interessati da un ciclo del carbonio di costante creazione e distruzione. Nelle foreste vergini gli alberi che muoiono sono distrutti da microorganismi, ma non completamente. Una parte della massa organica si accumula nel terreno, dove resta chiuso come in una cassaforte. Sotto lo strato di foglie, infatti, fa freddo e c’è umidità, condizioni che rallentano qualsiasi forma di vita. Da questi resti si creano nel corso di millenni gli stadi iniziali del carbone. All’incirca la metà della biomassa di un bosco è dunque immagazzinata nella cantina dell’ecosistema, ma solo a patto che l’uomo non intervenga. Non appena vengono tagliati gli alberi, luce e calore arrivano fino al terreno, favorendo la proliferazione di funghi e batteri che a loro volta decompongono il carbonio presente nel terreno. La cassaforte viene così svuotata e la CO2 immagazzinata torna nell’atmosfera.